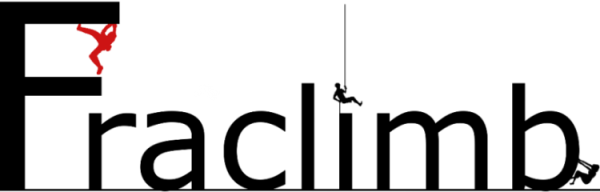ADLERAUGE – WELLHORN
domenica 26 luglio ’09
Con le braccia indolenzite a causa dei tiri strapiombanti della falesia di Lammi e con la
borsa dell’Ale sulle gambe, sono nuovamente seduto sulla macchina del Berna che sguizza tra i tornanti che conducono all’ingresso delle gole del Rosenlaui.
Il sabato, tolto l’intermezzo falesistico, è passato a bordo della Focus che ci ha condotti nel cuore della Alpi svizzere dopo aver valicato il passo
del Gottardo e l’interminabile Susten. Passeremo la notte al parcheggio del Rosenlaui, speranzosi che le nuvole si diradino lasciando lo spazio ad un cielo sereno.
Sono le 4:30 quando il cellulare del Lele trilla rompendo il silenzio che regna sovrano nella nostra tendina: io, lui e l’Ale ricomponiamo il trio
vincente della Dufour nella speranza di ottenere un nuovo successo sulle rocce del Wellhorn. A dormire in auto sono
rimasti il Berna e l’Helen che completano il quintetto che ambisce alla salita di Adlerauge.
Le pile illuminano il sentiero nel bosco, rompendo l’oscurità della foresta resa più tenue dalla luce delle stelle che brillano in cielo,
mentre in lontananza si riconoscono i caldi colori dell’alba. Il comodo sentiero sale ripido uscendo allo scoperto per poi risalire le pietraie un tempo non troppo
lontano custodite dai ghiacci perenni che ora si stagliano più a monte come un’invincibile muraglia. Le torri del ghiacciaio sono in precario equilibrio sull’orlo
di un salto roccioso e, minacciose, si protraggono verso la valle; durante la scalata saremo frequentemente accompagnati dalla roboante caduta di questi effimeri
torrioni ghiacciati infranti dal calore del sole.
Individuiamo rapidamente l’attacco. Abbiamo concordato che il ruolo di capocordata ricada sulle spalle del Lele, mentre io e Ale seguiremo a ruota: così dovremmo
garantirci una buona velocità che ci dovrebbe permettere di completare la via. I miei compagni optano per una salita in libera mentre il sottoscritto, con mentalità
più classica (e retrograda!) si formalizza meno ai dettami dell’arrampicata sportiva e guarda più al completamento della salita il più rapidamente possibile.
Questa filosofia si concretizza nella solita procedura del “ciapa e tira” anche se, a conclusione della salita, il bilancio avrebbe visto sgomitare l’arrampicata
sportiva nel tentativo di farsi valere sulla sorella maggiore, l’arrampicata artificiale.
I primi tiri sono ancora in ombra con il risultato che la progressione risulta influenzata: Lele si muove con la sua solita eleganza accarezzando gli appigli sfuggenti
e danzando tra le minuscole concrezioni su cui posa i piedi. Se da un lato è uno spettacolo vederlo muoversi sulla roccia, dall’altro i movimenti fluidi e leggeri sono
delle vere trappole ingannevoli, lasciando credere a chi li segue con lo sguardo che il tiro non presenti particolari difficoltà. Passano le lunghezze e gli zaini alla
base diventano sempre più piccoli e indistinguibili. Al termine del settimo tiro, su una comoda cengia, Lele passa il testimone: Ale (The Machine) è un po’ “grippato”
mentre il mio orgoglio mi spinge a passare in testa. Quindi mi lego anche la seconda corda e parto verso l’ignoto: sono preso da un raptus di voracità che mi fa
fagocitare le prese che incontro spingendomi rapidamente verso l’alto. L’arrampicata sportiva è oppressa: il mio orologio interno, il cui ticchettio mi riempie la testa,
mi impedisce di tentare ogni movimento in libera che non mi riesca prima di subito. In questo modo, i passi più impegnativi sono superati tirando il rinvio con il
vantaggio di farmi guadagnare rapidamente le soste terminali delle prime lunghezze che salgo da capocordata. Poi il ritmo diventa più blando, inconsciamente la
stanchezza comincia probabilmente a farsi sentire; non riesco a tenere il conto delle lunghezze, solo consultando la relazione mi rendo conto della nostra posizione e,
guardando l’orologio, mi accorgo del tempo considerevole a nostra disposizione. Man mano che il countdown delle lunghezze avanza, cerco di salire il più possibile in
libera forse influenzato dalla mentalità dei miei amici. Chiaramente non riuscirò nell’intento, ma almeno potrò dire di averci provato.
Non riesco a ricordare tiro per tiro, ma solo alcuni passaggi, alcuni momenti intensi, vuoi per la compattezza della roccia, vuoi per l’intensità dei passaggi.
In ogni caso la salita si rivela la giusta mescolanza tra il piacere del semplice arrampicare, di una roccia unica e dell’impegno nel cercare la via lungo i tratti
più semplici. Ricordo l’entusiasmo nell’allungarmi per afferrare il buco successivo, lo spostamento del piede, la frizione della scarpa su un calcare incredibilmente
aderente, ma anche il sapore dello smarrimento quando davanti ai miei occhi non si scorge alcuna protezione e allora, abbandonata la logica classica, mi trovo costretto
a spingermi verso l’alto fino alla sosta terminale.
Poi il conteggio arriva a meno tre: mi aspettano un 6a+ e due tiri sul V. Sono stanco, ma il miraggio della fine mi spinge a proseguire: lentamente supero il traverso
in diagonale e poi il muro verticale che mi porta su una stretta cengia erbosa. Davanti a me non ci sono altre protezioni: mi guardo in giro, il friend che ho
posizionato non mi ispira grande fiducia. Individuo un punto che sembra buono e, spinto dalla voglia di portare a termine la salita, lo supero raggiungendo la sosta.
Sono accolto da una piacevole sorpresa: il libro di vetta è custodito in una scatola metallica a lato della catena. Insomma, la via termina al 18° tiro, gli ultimi due
servono esclusivamente per raggiungere la cresta sommitale, ma non sono attrezzati per le calate. Preferisco non dir nulla agli altri, lasciando che scoprano la buona
notizia dopo avermi raggiunto. Così dopo circa 8 ore e mezza dal momento in cui ci siamo staccati da terra, lanciamo la prima doppia. La palla passa all’Ale che condurrà
l’infilata di doppie che ci avrebbe riportati agli zaini mentre, dal canto mio, mi rivelo piuttosto assente nella manovra lasciando ai miei due compagni gli oneri
maggiori.
Cavallo Goloso
Per lasciare un commento, clicca QUI