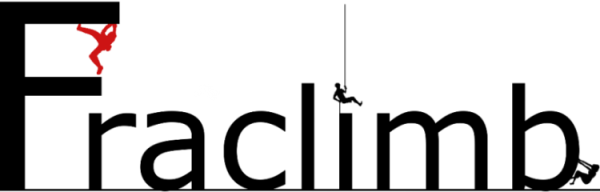DIRECT – VESTPILLAREN
domenica 11, sabato 17 agosto ‘19
Quando Walter mi propone la spedizione di Ferragosto in terra norvegese, non ci penso su due volte: ovvio che mi interessa! Poi a febbraio prendiamo i biglietti e l’attesa diventa qualcosa di reale: dovremmo andare a fare fessure per abituarci allo stile delle isole ma poi, come ovvio, finisce che continuo a tirare tacche e fare la scimmia su qualche strapiombo così, quando stiamo imbarcando i sacchi, la mia preparazione in materia è pressoché nulla. Ma non è tanto quello il fatto: sono le condizioni al contorno che sono cambiate. Da un lato non mi avrebbe dato poi troppo fastidio mandare all’aria tutto: è anche vero però che una settimana passa piuttosto in fretta. O forse no?
Quando scendiamo dall’aereo, fuori c’è ancora luce nonostante siano le 10 passate. Questo dovrebbe aiutarmi a non finire con un tuffo triplo carpiato sul fondo di un qualche fiordo visto l’arretrato di sonno per aver fatto visita al pronto soccorso di Erba dopo che la caviglia di Jolanda aveva fatto di tutto per partire in orbita tornando dal Cornizzolo. Individuiamo l’auto (un barcone a quattro ruote di cui non si scorge ne capo ne coda), la carichiamo e quindi mi appollaio al posto di guida. Immediatamente un grosso punto di domanda si materializza sopra il mio testone quando la tecnologia moderna ce la metta tutta per infilare i bastoni tra le ruote proponendomi un mezzo con due pedali e il cambio automatico. Scavo tra i ricordi, tiro fuori quei miseri avanzi delle poche esperienze con auto simili e ci ritroviamo in strada finchè, a mezzanotte passata, la notte ha oramai calato il sipario e pure le mie palpebre paiono voler fare la stessa fine. Supero un’area di sosta, mi fermo, giro la macchina e, una manciata di minuti dopo, siamo entrambi infilati nei rispettivi sacchi a gustarci la prima ronfata norvegese.
Lunedì, giustamente, lo dedichiamo a capire quale sia la differenza tra le nostre capacità e le difficoltà delle pareti e così optiamo per una salita che, stando alla relazione, dovrebbe essere piuttosto semplice. Dopo aver quasi sbagliato il sentiero d’accesso, aver rapidamente recuperato dal madornale errore e aver completato un avvicinamento su muschi che sembrano un tappeto salterello e che ci richiede bene o male il tempo e l’impegno fisico necessario per andare in falesia, ci troviamo alla base della via. Parte il Walter che subito capisce cosa significhi scalare da queste parti: protezioni pari al nulla cosmico e soste che, quando ci sono, fanno rizzare i capelli anche a Bisio. Poi arriva il mio turno e me la devo vedere con una placca sprotetta, tipo quelle da spiaccicamento in Valle. Ok, è solo V ma se dovessi cadere, oltre ad incendiarmi come un cerino, rotolerei sotto il Walter con un pendolo infinito! Capita l’antifona e confermata per l’ennesima volta l’aderenza delle scarpette, per il resto ce la caviamo abbastanza bene: superiamo un diedro un po’ scorbutico dove completare la colorazione delle mutande quindi uno strapiombo ben ammanigliato in cui mostro al Walter le mie abilità acquisite con le sedute sulla plastica milanese e poi, proprio all’uscita, ci incartiamo col caianesimo vegetariano. Praticamente l’unica differenza con la val di Mello è che qui si parte dal livello del mare ma, per il resto, è tutto uguale: la roccia è da urlo, si urla sui tiri e di più alle soste perchè sui primi ci si caga addosso e alle seconde si è proiettati in un libro di Stephen King. Poi c’è la verdura: licheni, muschi e piante che insieme sono gli amici-nemici del buon caiano. Così spingo sul substrato vegetale, mi afferro ai rami come un babbuino e esco dalla parete. Sopravviviamo alle doppie (a dire il vero credo di averne fatte di ben più scabrose) e siamo di nuovo sul tappeto di muschi che guarda l’anfiteatro di pareti. Solo che è ancora presto e qui il sole non ha la minima intenzione di andare a fare un pisolino così torniamo verso il campo, un bucolico praticello che si affaccia su una ridente insenatura, con l’idea di salire una linea che si trova proprio sopra le nostre teste. La fessura del secondo tiro è già occupata ma, appena avremo finito di fare l’Indiana Jones nella foresta che ci separa dalla vicina parete, quei tre saranno certamente già all’uscita della via. Infatti, dopo pochi minuti che il Walter è sparito dalla mia vista, eccolo incagliato sotto le chiappe dei due che aspettano che la capocordata li recuperi come due sacchi da parete dopo aver probabilmente fatto uso di tutti i trucchi per venire a capo della spaccatura. Sono in sosta a fracassarmi in attesa che sopra si smuovano quando un oggetto metallico non ben identificato mi passa davanti; l’oggetto rimbalza poco sotto i miei piedi e si va a fermare su un masso poco più in basso. Secchiello-piastrina! La capocordata in alto ha avuto la brillante idea di farselo scappare di mano e ora si ritrova a guardare come un pesce lesso le corde, i suoi compagni e la ferraglia che gli rimane. Chiaramente non ha la minima idea di come si faccia un mezzo barcaiolo. Per fortuna che c’è internet e qui non siamo in Valle: da sotto cercano su Google, imparano alla svelta e provano a insegnare a quella di sopra. Il tutto accompagnato da uno sfacelo di risate. Sulle Alpi, dove vige la ferrea legge caiana, sarebbero volate le Madonne. Paese che vai, usanza che trovi. Siccome già non è proprio facile imparare a distanza come fare un mezzo barcaiolo e considerando che il telefono senza fili non è proprio il mezzo di comoneunicazi più efficacie, ci bastano pochi minuti per capire che le possibilità siano solo due: o restiamo qui a bivaccare o, molto probabilmente, dovremo assistere allo spiattellamento della cordata con annesso impataccamento con sostanza organica umana di alberi e pareti. La cosa non mi va molto giù, così salgo dal Walter e poi parto sulla fessura. La cosa che più temo è fare la figura del cioccolataio e trovarmi ad arraffare ogni protezione per avanzare di qualche centimetro annaspando come un pesce fuor d’acqua. Invece alla fine riesco anche a cavarmela relativamente bene; trovo lo spazio per fare una sosta, restituisco il secchiello alla legittima proprietaria e quindi recupero il Walter. Dopo altre due lunghezze di cui aggiriamo saggiamente il tratto più scabroso su placca verticale della morte certa, ci troviamo in cima alla parete e, da lì, in una manciata di minuti fuori dalla tenda ad aspettare che la cena venga pronta. Quella sera in TV danno “bradipi in parete”: ce lo cucchiamo tutto, quasi in prima fila. La cordata infatti ci impiega una mezza eternità per venire a capo delle due lunghezze rimanenti, il tempo necessario per terminare il risotto del Walter e digerire il tutto.
L’indomani cogliamo la palla al balzo della prestazione del primo giorno e optiamo per giocarci subito la carta vincente della spedizione, tentare una big wall delle isole: la Vestpillaren Direct, la classica via senza possibilità di ritorno se non volendo abbandonare l’intero armamentario che ci scorrazziamo all’imbraco. Così lasciamo il campo e ci avviamo verso la vicina parete, una lavagna verticale che praticamente si erge quasi dal mare per circa 500 metri di pura lotta caiana senza lo sbattimento degli avvicinamenti del Masino. All’attacco troviamo un’altra cordata che, dopo pochi tiri, sparirà dai nostri radar caiani. Questa volta inizio io e mi sento forte. La sensazione durerà una manciata di tiri, poi l’istinto di sopravvivenza avrà ancora la meglio e mi troverò a combattere l’ennesima lotta con l’alpe. La roccia è perfetta, una linea di fessure e diedri che taglia la parete come una fetta di formaggio. Fortuna vuole che le nostre tecniche trogloditiche siano più che sufficienti a far scorrere la roccia sotto i nostri piedi tanto da non vederci costretti a mitragliare le spaccature con tutti i nostri ferri. All’inizio poi la via si mostra anche magnanima, con i primi quattro tiri sormontati da soste con catene che terrebbero su un transatlantico, peccato che sia solo uno specchio per le allodole, uno zuccherino per farci invischiare ancora di più nella merda: dalla quinta lunghezza in avanti entriamo nel nulla cosmico, senza alcun minimo straccio di sosta. Alla settima lunghezza comincio a domandarmi perchè cavolo mi vengano certe idee: ma non potevo starmene a casa con la Jolanda? Guardo la fila di friends che sembrano le bocce di Natale sull’albero e poi la sosta rigorosamente su protezioni mobili. Inizio a sbarellare. Il problema è che devo per forza andare avanti, non abbiamo alternative. Le studio tutte ma alla fine desisto: il friendino giallo è una tentazione troppo grossa e alla fine assecondo le sue volontà e lo tiro. Lui non mi tradisce e io mi salvo ancora una volta. Il problema è che più avanti avremo un’altra lunghezza sulle stesse difficoltà. Mi sento come il condannato nel braccio della morte in attesa del suo triste destino. Invece questa volta le cose vanno decisamente meglio: il diedro che rimane ben nascosto dalla sosta, non è poi così scorbutico e si lascia salire senza eccessive difficoltà. Anche questa volta dovrebbe esserci andata bene, ci resta solo la discesa, un sentiero che pare una pista verticale su terra e sassi in cui è meglio assecondare la forza di gravità e rotolare verso il basso.
Mercoledì siamo fortunati: piove! Ergo: giorno di riposo. Per prima cosa dilapidiamo un po’ di quattrini in un ristorante sperduto nel nulla per poi dirigerci alla punta estrema della Lofoten e al relativo paese di A. Al rientro però mi sento in colpa: sono qui per scalare e al terzo giorno ho già buttato la spugna? La verità è che soffro l’assenza dei fix, dei solidi, confortevoli, rassicuranti tasselli infilati in un buco artificiale nella roccia. Sono un caiano moderno: l’intransigenza va bene ma fino ad un certo punto. Così alla fine eccoci a provare gli strapiombi di una falesia locale e scoprire che, se vogliono, i norvegesi sanno piazzare le protezioni senza lesinare.
Giovedì siamo ancora marci e alla fine ce ne stiamo a gironzolare tra i massi vicino al campo, giusto per sperimentare un po’ di arrampicata in fessura in previsione di qualche altro grosso colpo che in realtà non arriverà mai. Forse, col senno di poi, sarebbe stata meglio una giornata di stacco completo ma l’idea ci pare una blasfemia e così ci impegniamo a cuocerci per benino mentalmente e psicologicamente.
Poi arriva venerdì e io termino la cottura e raggiungo il mio tracollo. Non ne posso più. Tornerei volentieri a casa ma mi trovo relegato qui al nord e per di più mi tocca scalare. Non avrei mai pensato di dirlo. Optiamo per una parete poco più a destra del Vestpillaren, un posto che probabilmente in altre occasioni non avrei mai cagato di striscio: vie troppo corte e facili. Solo che ho il cervello letteralmente in pappa, una brodo primordiale che galleggia nella scatola cranica. Praticamente mi trascino su per la parete lottando ferocemente contro la pazzia che a tutti i costi vuole impadronirsi di me. Scalare su protezioni mobili, affidarmi a soste costruite da noi mi da il voltastomaco. Non mi sento per nulla sicuro, ho il terrore che il piede mi possa scappare da un momento all’altro, che le protezioni si aprano come una zip. E il problema è che abbiamo scelto una via relativamente semplice; forse questa, in realtà, è la mia salvezza: riesco a portare le mie chiappe in salvo in cima alla parete per poi tornare giù e rimettermi all’opera. Walter sembra invece totalmente impassibile, come se fossimo al primo giorno di scalata. Così eccoci a risalire per un’altra via e poi per una terza. È come essere in Antimedale solo che io sono svuotato, un sacco di patate privo del suo contenuto: raschio sul fondo e, col poco che tiro su, arrivo alla conclusione di questa giornata.
Sabato è l’ultimo giorno, domani ci aspetta l’aereo e, non lo nascondo, la cosa non mi dispiace affatto. Solo che sono ancora nel loop scalatorio: andarmene senza mettere le mani sulla roccia mi pare un sacrilegio, un’occasione persa. Così scoviamo una bella falesia (perchè di vie ne ho fin sopra i capelli) di placca dove mi faccio assicurare dal Walter che invece ha appeso le scarpe al chiodo. Riesco anche a fare quasi una buona performance dopo le giornate passate ad avere la tremarella per la protezione troppo lontana e inaffidabile mentre le forze vengono meno a furia di tirare fessure senza esserne capaci. Qui è un’altra storia: sono protetto da solidi fix e devo solo fare affidamento al grip tra scarpette e granito. Un puro godimento dell’arrampicata in attesa di chiudere la vacanza come l’avevamo aperta: con un bivacco improvvisato poco lontano dall’aeroporto e sotto una flebile pioggerellina.
Cavallo Goloso
Per lasciare un commento, clicca QUI