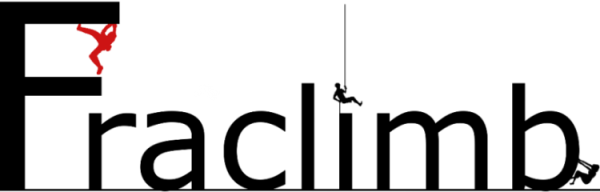BWANA MALINE, AFIN QUE NUL NE MEURE e 36-15 - VERDON
venerdì 03 - martedì 06 aprile ’10
Siamo esterrefatti: dal pulmino parcheggiato dietro la nostra auto continuano a scendere delle gran gnoccolone. Da che siamo arrivati all'ostello nizzese, è un continuo susseguirsi di bionde stangone nordiche: partiti per scalare in Verdon, sembra che la vacanza si stia trasformando in un seminario sulla lussuria, ma poi ci infiliamo sotto le coperte senza combinare nulla mentre mi passano davanti le scene di Hostel di Tarantino. La notte scorre comunque liscia come l’olio eccezion fatta per la fattona ubriaca che, dopo aver cercato disperatamente di buttar giù la porta, si rinchiude nel nostro bagno costringendoci a chiamare un responsabile per stanarla e scoprire che è un’inquilina di un’altra stanza! E’ quindi la volta del taglialegna svedese dell’Ikea che dovrebbe dormire nella nostra camera ma che preferisce dare il via al turno notturno della propria segheria.
La mattina, dopo aver soddisfatto la gola con la colazione lauta e leggendaria per un gruppo di anoressici vegani (infinite qualità di cereali e i classici pane burro e marmellata) non perdiamo tempo a lasciare questo luogo di perdizione per raggiungere il nostro sballo: tanto la vacanza ci darà innumerevoli occasioni per riservarci un accogliente posticino nel girone dei golosi! Arriviamo a La Maline, il nostro campo base, sotto un cielo grigio e minaccioso. Senza lasciarci intimidire dalle condizioni patagoniche, buttiamo la prima doppia nell’antro del Verdon; fiume che, in assonanza con il nome, è proprio verde anche se la Silvia ci reguardisce sul fatto che in realtà il nome non centra un fico secco col colore delle sue acque.
Il Verdon va preso a piccoli bocconi, così il nostro mentore e conoscitore di ogni linea che risale dal canyon ci propone una breve salita “Bwana Maline” la cui roccia compatta e a gocce è unica; certo, questo dev’essere il regno degli eccessi: uno stillicidio a cascata deve aver scavato queste forme che rassomigliano a delle vere e proprie vaschette dove infilare le dita. La dea bendata, sorella di Giano bifronte, ha nel frattempo voltato il suo sguardo, mostrando la brutta faccia della rogna: una fastidiosa pioggerellina cade a tratti da un cielo tipo inverno milanese mentre il nostro unico ombrello è costituito dallo strapiombo che ci sovrasta.
La domenica è passata nella totale inattività arrampicatoria: piove a sprazzi e, vagliate le numerose opportunità offerte dalla regione (una sbronza alla brasserie, un giro nel negozio di articoli sportivi o il tepore del piumone), non ci rimane che optare per il turismo giapponese. Armati con le nostre macchinette, diamo inizio al trasferimento su supporto digitale di ogni edificio dell’interessante borgo di Moustiers-Sainte-Marie, con il rischio personale di ricevere la scomunica familiare per aver passato in perfetta indifferenza la domenica di Pasqua. Al pomeriggio il tempo migliora e ritorniamo a sprofondarci verso il letto del torrente: la spedizione punta a raggiungere la Mescla ma vede i partecipanti rinunciare all’ambito obiettivo il cui nome campeggia sulla porta della nostra camera.
Poi arriva lunedì: gabbata dalla festività pasquale, la dea bendata torna a rivolgerci il suo lato migliore e il disco dorato del sole ci saluta mentre ci caliamo non lontani da uno dei numerosi belvedere che si affacciano sull’orlo del baratro. Già dal primo giorno, abbiamo potuto ammirare estasiati il volo dei numerosi grifoni che regnano nel cielo del Verdon ma, dimentichi degli insegnamenti di Piero Angela, continueremo a chiamare queste galline volanti, che ripetutamente girano sopra le nostre teste, con i più svariati nomi del regno animale.
Divisi in due cordate da tre, la nostra guida opta per l’assicurante “Afin que nul ne meure” con uscita su “36-15” giusto per aggiungere un po’ di peperoncino alla salita: la roccia segnata dai passaggi continua comunque a mantenere un’ottima aderenza, mentre l’esposizione non è proprio quella delle foto da rivista. E intanto un condor ci svolazza accanto. La scalata è superba: ci sono tutte le prese necessarie scavate in una roccia incredibilmente compatta, l’ambiente circostante è poi unico nel suo genere.
Usciamo dalla via che la voglia di arrampicare è amplificata; e con spirito da FF, ci ricaliamo nella spaccatura in corrispondenza del guardrail. La preoccupazione maggiore non è rivolta tanto al monotiro, quanto alla possibilità che l’obiettivo della macchina fotografica riesca a catturare i nostri movimenti: comunque, per non fare figuracce con i numerosi turisti, scegliamo rigorosamente tiri tranquilli che ci facciano sembrare capaci di scalare. Tanto qui la roccia è talmente strepitosa, “orgasmatica”, che calarsi a destra o a sinistra non ha alcuna importanza! Altezzosamente svolgiamo le nostre manovre, mentre l’ignoranza petulante dei curiosi si manifesta con perle indimenticabili: “ma poi risalite?” “no, guarda: ho già ordinato la cucina per l’anfratto qui sotto!”; “ce ne vuole di coraggio...” “mai quanto quello per fare certe uscite!”.
Mentre si scala, l’unica remora è legata al passaggio degli insulsi pterodattili, invidia dello scalatore di turno al quale sorge il dubbio che l’obiettivo del fotografo sposti il proprio focolare verso l’uccellaccio mancando di immortalare il perfetto movimento del momento.
Purtroppo come ogni sogno c’è anche il risveglio della realtà che sopraggiunge all’invenire del nuovo giorno; abbiamo solo mezza giornata e poi ci attende il rompimento del viaggio di ritorno. Consumata l’ultima colazione preparata col fornelletto in rispetto delle tradizioni che vedono gli alpinisti come oculati risparmiatori, ritorniamo al belvedere del lunedì con l’idea di scalare nuovamente sui monotiri. Si ripetono così le scene della giornata precedente, questa volta rese ancora più ridicole dallo spuntare di un paio di walkie talkie che utilizziamo per comunicare con lo sborone di turno calatosi lungo l’ultimo tiro di Pichenibule. Qui il vuoto e l’esposizione sono spaziali e rasentano la nausea: lo sbocco da quaggiù raggiungerebbe facilmente quel cretino con il caccia che interrompe col suo passaggio roboante il silenzio della gola rischiando oltretutto di arrostire i numerosi tacchini volanti.
Chiassosamente come era giunta, l’onda barbara lombarda è costretta a lasciare questo Eden. Una curva dopo l’altra il ritorno alla civiltà è piuttosto traumatico; una lunga colonna ci saluta dall’autostrada lasciandoci col filosofico quesito: ma tutta sta gente qua, perchè non se ne sta a casa propria?
Cavallo Goloso
Per lasciare un commento, clicca QUI