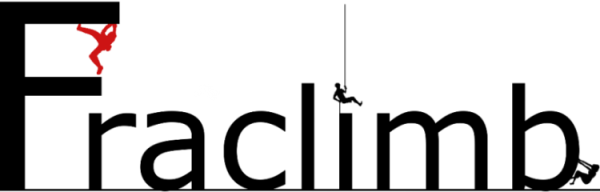BONATTI – GRAN CAPUCIN
sabato 23 giugno ‘12
Svuotato. Prosciugato, afflosciato come un sacco vuoto. Mi trascino per la Combe Maudit: il sole picchia impietosamente sulla mia figura che vaga in questo deserto innevato. E l’occhio torna a martellare, un dolore lancinante, insopportabile. Mi fermo, poi passa: mi sembra stia migliorando ma già immagino ogni peggior scenario. Non mi volto nemmeno a guardare lo slanciato obelisco dal Gran Capucin ma sento comunque il suo ghigno beffardo mentre ci osserva arroccato sul suo trono.
Arriviamo al parcheggio della funivia di Courmayeur venerdì sera, davanti ai nostri occhi si profila il sogno: vedo il granito rosso, ne tocco le rugosità , solco le sue fessure. Se ce la facciamo saremo sommersi dai bollini, cammineremo dieci metri sopra la terra e, ci diciamo, potremmo anche considerare conclusa la stagione. Ma è ovvio che non sarà così e lo sappiamo entrambi.
Un granello di sabbia deve essermi entrato nell’occhio: lo lascio perdere e ci dormo sopra.
La mattina c’è già coda alla funivia ma, nonostante tutto, riusciamo ad essere al Torino quasi in orario. Ho lo zaino bagnato: quella maledetta borraccia ha deciso di aprirsi riversando il suo prezioso contenuto dentro il mio sacco; praticamente sono senz’acqua in mezzo ad un mare di neve. In cielo brilla un sole incredibilmente caldo, il cielo è completamente sgombro di nubi e il Gran Capucin si staglia perfettamente pulito da questa bianca distesa: la giornata ideale in totale solitudine. Il cuore sobbalza mentre l’occhio inizia a dare qualche debole fastidio ma non è nulla di che.
Decidiamo di raggiungere l’attacco della Bonatti passando per le omonime terrazze e quindi ci infiliamo in quel budello del canale a sinistra della parete. Bisogna salire in fretta: una pietra che cada dall’alto si infilerebbe lì e la giornata prenderebbe una piega decisamente storta. Superiamo la nostra roulette russa e iniziamo a progredire a tiri alterni. Risalgo per rocce rotte cercando il passaggio più semplice per la terrazza principale ma sono un codardo e alla fine sosto. Il duro lo risolve Cece: passando da un camino intasato di neve e ghiaccio riesce, non so come, a superare lo sperone roccioso che ci divide dalla vera arrampicata. Mi sento scombussolato, come se fossi in una campana di vetro in un ambiente ovattato. Risalgo quell’infido passaggio chiedendomi se mai l’avrei superato da primo e quindi raggiungo l’amico. L’occhio da fastidio.
Abbiamo perso tempo, ho perso tempo ma iniziamo comunque la nostra salita; o meglio: la nostra discesa e quindi la traversata alla base del primo diedro. Mentre scalo, sono interamente preso dall’azione, intorno a me non c’è più nulla: siamo solo io, la roccia e la forza di gravità. Poi in sosta, l’occhio inizia a picchiettare. Parto per la prima lunghezza impegnativa e già sui primi metri tiro tutto: il friend, il chiodo con l’anello rotto e quello con l’anello spiattellato contro la roccia. Raggiungo un terrazzino e ho già le braccia rotte. La mia battaglia continua: il diedro sale verticale e con esso una fila di chiodi: li tiro quasi tutti, raggiungo un ballatoio chiuso da uno strapiombino e anche lì afferro la protezione e mi isso sulla parete. Un altro diedro e la scena si ripete: è una corsa tra un chiodo e l’altro o al massimo dal friend al chiodo e poi sono in sosta.
Lo svarione arriva: prendo un po’ di miele e intanto recupero Cece. L’occhio inizia a fare male. Mi viene voglia di scendere, abbandonare quel sogno tanto accarezzato ma non dico nulla all’amico e lo lascio preparare alla lunghezza successiva. Mi sento in trappola, tra la cocciutaggine, la voglia di non fallire come fossi obbligato a calcare la cima del Gran Cap e l’effettivo desiderio di scalare la Bonatti. Arrampicare? Fin’ora a parte lo zoccolo e qualche metro prima di calarci verso la sosta del diedro, praticamente ho solo tirato chiodi e la situazione non si profila tanto differente.
Non dico nulla e lascio partire Cece; a guardare verso l’alto il dolore diventa insopportabile. Cece si struscia nel camino e raggiunge il diedro strapiombante sovrastante. Ogni chiodo si trasforma in un provvidenziale appiglio, indispensabile per raggiungere la sosta. Il tiro successivo é uguale, un lancio dietro l’altro verso l’anello metallico. Poi c’è il traverso: mi sposto verso destra su una placca di quinto ma, dopo aver tirato ogni cosa, anche il più semplice movimento in arrampicata diventa un ostacolo insormontabile. I chiodi salgono diritti verso il tetto che chiude la placca. Poi ci si sposta all’estremità destra, dove il tetto finisce e si profila un diedro. Praticamente è come se fossi al vertice interno di un cubo: sopra la mia testa il tetto, a destra la faccia del diedro mentre io sono sospeso sull’altra. Piazzo un C3 in corrispondenza del bordo del tetto ma quest’ultimo, se da un lato mi ha permesso di infilare la protezione, dall’altro mi impedisce di proseguire. Non ho altre possibilità se non quella di passare sulla faccia destra del diedro ma più in basso dove la parete è solcata da una fessura. Sono preso da un attimo di sconforto che mi lascia maledire questa via ma poi mi impongo un certo autocontrollo: devo tornare indietro, togliere il C3 e sfilare la corda da tre rinvii. Per fortuna i pochi passi d’arrampicata non sono impegnativi e così torno sul traverso in placca. Riprendo a muovermi verso destra fino al diedro e alla sua faccia destra solcata dalla provvisoria fessura verticale. Raggiungo il chiodo alla base e quindi piazzo due friend: tiro la prima protezione e staffo sulle restanti e finalmente sono alla sosta e al primo bivacco Bonatti. Il posto è confortevole se non fosse per alcune vecchie scatolette arrugginite: la maleducazione non ha limiti!
Recupero Cece visibilmente seccato per il continuo ed eccessivo tirare di chiodi. Anch’io non mi sto particolarmente divertendo, in più l’occhio non sembra volermi concedere una tregua anche se il dolore sembra attenuarsi: mi sento un po’ meglio ma, nel complesso, non sono in forma; per di più l’ipotesi di un bivacco si fa sempre più certezza: sono quasi le due e abbiamo davanti a noi ancora 9 lunghezze. Insomma è un insieme di fattori che mi fanno accettare la proposta di Cece: scendere. Non ho la forza per ribattere ma non ne ho nemmeno la voglia.
Praticamente scendo grazie al lavoro del mio amico: ad ogni doppia l’occhio sembra voler scoppiare costringendomi a ripetute fermate finché finalmente torniamo sul ghiacciaio.
Voglio solo raggiungere il rifugio, farmi spennare e affondare la testa in un cuscino ma le difficoltà non sono finite: il rifugista, evidentemente scocciato perchè non abbiamo prenotato, ci assegna due posti in un camerone. La reazione dell’uomo mi fa alquanto girare le scatole: siamo in un rifugio, non in un albergo, questa storia della prenotazione sta diventando veramente insopportabile!
Salgo le scale alla ricerca della mia branda: il gruppo del CAI ha ben pensato di lasciare solo un letto libero e, solo dopo aver girovagato a destra e a sinistra scovo finalmente il materasso dove passerò la notte.
Domenica il sole splende ancora alto nel cielo, l’occhio sta decisamente meglio, praticamente è quasi tornato normale ma comunque lasciamo perdere ogni sogno di gloria e prendiamo la funivia per Courmayeur. Il Bianco ha perso il suo fascino: i miei limiti palesatisi nella giornata di sabato hanno avuto l’effetto di una falce. Ma quando l’erba viene tagliata poi cresce ancora più forte!
Cavallo Goloso
Per lasciare un commento, clicca QUI